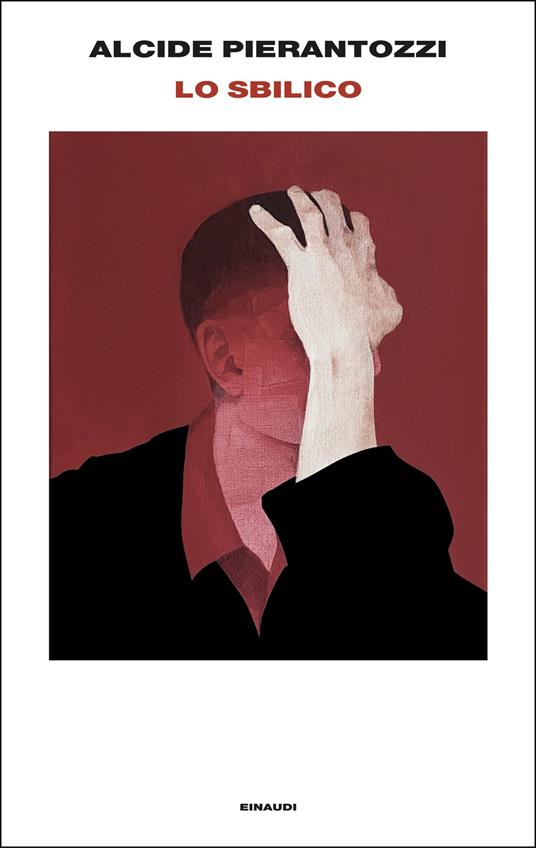Il titolo, intanto: Lo sbilico1.
“Bilico” è un termine-chiave. Significa “stato di instabilità, di equilibrio precario” (come nell’espressione “tenere in bilico” o “essere in bilico”). Quindi, “sbilico” significa “essere fuori dal proprio bilico”, ossia uscire da uno stato di equilibrio precario. Rappresenta l’istante in cui si perde completamente l’equilibrio, sia fisico che mentale. È il momento della caduta, dello sbandamento, dello smarrimento panico.
Pierantozzi spiega di essersi ispirato alla famosa scena del film Joker (2019) di Todd Phillips, in cui il protagonista, Arthur Fleck, ha un attacco di riso incontrollabile e disperato mentre è sul treno. Quel riso che sembra pianto, il momento di follia pubblica e di perdita di controllo, è l’essenza dello “sbilico”. È il punto di passaggio, di transizione brutale tra uno stato e l’altro (dalla disperazione all’euforia, dal controllo alla perdita totale).
Lo sbilico è una ricerca di parola su questi momenti che si susseguono in un un cronotopo elicoidale, in cui passato e presente si mescolano nell’eternità della sofferenza mentale. Ricerca lucida, efficace, sulla quale è difficile scrivere, essendo il romanzo autobiografico, un corpo vivo ed esistente, a differenza per esempio de Il passeggero e di Stella Maris di Cormac McCarthy, percorso capillare nella schizofrenia dove lo sguardo autoriale è distaccato rispetto ai personaggi. Come parlare criticamente, invece, di una sofferenza viva? Come recensire la sua evidenza senza violarne in qualche modo un’intimità che chiede forse solo il silenzio di una lettura traumatica e a suo modo estasiata dall’intensità?
Un libro così particolare chiede comunque parola, almeno frammentaria, articolata su suggestioni. Per esempio perché l’autore è gay e vede il mondo e se stesso da una prospettiva queer ( in un certo senso il termine queer è in sé affine all’area semantica di “sbilico”). Perché il pene sulla cui potenza-impotenza tanto Pierantozzi riflette, e su cui letteralmente si flette per mapparne ogni stato, desidera penetrare altri maschi. Perché il corpo è visto anche in questa prospettiva desiderante, e la neurodivergenza dell’autore nasce, almeno in parte, dalle difficoltà adolescenziali a vivere l’omosessualità.
Anche il momento subito necrotizzato di un sex toy (vagina spugnosa) ricade nella prospettiva di sbilico. Si pensa a un testo come No Future di Lee Edelman (2004), dove la pulsione di morte veniva comunque letta come un momento fondante della prospettiva queer. Prospettiva simile a quella di Teresa de Lauretis, fra l’altro.
Il tema specifico della morte del fratello disabile e appena nato, in Pierantozzi, invece, ci conduce un punto di frizione centrale: per Edelman, il “Bambino” è il simbolo da rifiutare in blocco perché rappresenta il futuro eteronormativo. Per Pierantozzi, il “bambino” morto (il fratello) è un fantasma personale con cui deve fare i conti per ricucire la propria identità psichica.
Per Edelman il “Bambino” è una figura astratta e simbolica, l’incarnazione del Futuro Riproduttivo ed Eteronormativo. La queerità deve opporsi a questo simbolo per sabotare l’ordine sociale. In Pierantozzi il fratellino morto non è un simbolo, ma una persona in carne ed ossa, legata a lui da un lutto che produce sbilico.
Edelman invita a abbracciare la pulsione di morte in modo negativo e anti-sociale, per far crollare le strutture simboliche esistenti. È un “no” radicale al futuro. In Pierantozzi la scrittura è un atto, pur sghembo, di ricostruzione del sé (non casualmente è un lettore di poesia). La scrittura è un tentativo di creare senso, non di divellerlo radicalmente.
In Edelman la politica queer è proiettata contro un futuro ideologico. In Pierantozzi la battaglia è tutta rivolta all’interno, se si esclude un atto di sabotaggio (immaginario) contro una palestra. Il progetto è archeologico: scavare nel passato per rendere meno doloroso il presente e, forse, permettere un futuro personale (non collettivo) più vivibile.
In Edelman la teoria è radicalmente anti-edipica e anti-familiare, rifiuta la famiglia come istituzione normativa. In Pierantozzi il dramma è profondamente familiare e intriso di dinamiche “edipiche” (il rapporto con la figura del padre, chiamato proprio edipicamente il Negazionista, il lutto familiare, la madre pervasiva). La famiglia, per quanto luogo di trauma, rimane il quadro in cui l’esperienza soggettiva si svolge e da cui non si può prescindere. Pierantozzi non la rifiuta in toto, cerca di ripararne le fratture, ricostruendo una fratria originaria tra fratelli maschi, persino in luoghi davvero impervi, come stabilimenti balneari abusivi con amplificatori musicali snervanti, palestre di provincia trasudanti omofobia o i treni che collegano l’Adriatico a Milano, tra un susseguirsi di crisi psicotiche.
Paola Guazzo
- Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, Einaudi, 2025.[↩]