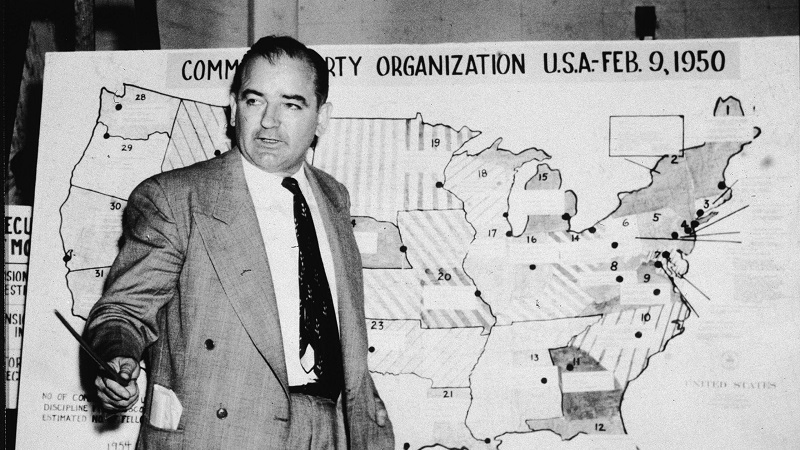È ormai avviata, di fatto, la discussione relativa agli schieramenti che si presenteranno alle elezioni politiche italiane del 2027. Questo impone anche alla sinistra di trasformazione di avviare un confronto largo sulle opzioni possibili e sulle modalità di presentazione a questo appuntamento che per molti aspetti sarà cruciale per tutta una fase politica.
Da ora alle elezioni politiche, che presumibilmente si terranno nell’autunno del 2027, vi saranno altre scadenze che potrebbero modificare il quadro al momento prevedibile: dalle prossime elezioni regionali, ad alcuni importanti appuntamenti in città cruciali e inoltre si terrà il referendum sulla legge per la separazione delle carriere dei magistrati.
Oltre a queste scadenze che mobiliteranno tutto o parte del corpo elettorale sono possibili altri mutamenti del contesto politico e sociale, dall’andamento dell’economia all’impatto dei conflitti militari in corso, alle mosse delle varie potenze, a partire dagli Stati Uniti di Trump.
In un contesto globale di grande incertezza e di incremento delle tensioni e dei conflitti nei diversi ambiti non è facile prevedere quale sarà esattamente il quadro che si presenterà nell’autunno del 2027. È però indispensabile, se si vogliono impostare un progetto e una strategia, determinare alcuni elementi fondamentali della fase che viviamo e alcune ipotesi di sviluppo, quanto meno nel medio periodo.
Non c’è dubbio che il contesto sia globale che nazionale siano diversi da quelli del decennio scorso. Oggi il dato fondamentale è l’ascesa di una destra autoritaria e reazionaria con elementi di fascismo. I recenti risultati elettorali positivi in Irlanda e a New York indicano la possibilità di una inversione di tendenza, ma non sono ancora tali da indicare una vera controffensiva della sinistra e delle forze progressiste. Come dimostra il dato politicamente più significativo, perché influisce sulla direzione politica nazionale, com’è l’esito del voto in Argentina, dove si è consolidato un blocco elettorale che unisce destra tradizionale ed estrema destra.
A sostegno di politiche di estrema destra si è andata orientando una parte importante delle classi capitalistiche dominanti, sia essa espressione di settori tradizionali (il fossile) sia di imprese di punta nel rinnovamento tecnologico del capitalismo (le Big Tech), o anche di potentati finanziari che per altro restano saldamente intrecciati agli uni e alle altre. Questo è l’esito di uno spostamento rispetto alla fase precedente nella quale il grande capitale puntava ad una convergenza centrista attraverso la quale poter gestire indifferentemente da destra o da sinistra forme di neoliberismo più o meno aggressivo.
In Italia, quella fase aveva visto parti maggioritarie del capitalismo orientarsi, di fronte alla crisi della leadership berlusconiana, verso un PD diretto da settori centristi (Renzi, Gentiloni, Letta), prevalentemente ma non esclusivamente di provenienza democristiana, oppure verso tecnici che per ruolo e biografia hanno sempre svolto la funzione di gestori degli interessi capitalistici (Monti, Draghi).
Il successo della destra a guida neofascista, determinatosi nel 2022, ha anticipato una tendenza più generale. Se inizialmente poteva esserci qualche perplessità sulle capacità della guida di Giorgia Meloni di gestire il governo in accordo con gli interessi del potere economico, questi tre anni hanno dimostrato invece che questa convergenza è pienamente realizzata.
La direzione politica impressa da Giorgia Meloni tiene insieme due elementi diversi ma non contraddittori. Da un lato il tentativo di evitare qualsiasi conflitto con i poteri di fatto, al di là delle convergenze ideologiche. Questo è valso sia per gli Stati Uniti di Biden che per quelli di Trump, per la Commissione europea di Von der Leyen, per l’Israele di Netanyahu o persino per la banda criminale di Almasri in Libia.
L’ossequio al potere, che rende così disponibile il Corriere della Sera nella difesa del governo, va di pari passo con un’operazione politico-ideologica di smantellamento delle premesse valoriali della Carta costituzionale, in attesa di poterne progressivamente svuotare i contenuti operativi. Estensione del controllo dei media e trasformazione degli apparati educativi in strumenti ideologici a fini reazionari e revisionisti sono aspetti importanti della politica del governo. A questo si aggiunge la strategia di criminalizzazione di tutti i movimenti sociali critici dell’ordine esistente e anche di polarizzazione sociale tra i “benpensanti” e tutti coloro i cui comportamenti potrebbero mettere in discussione un assetto socio-culturale reazionario.
Le elezioni del 2027 saranno quasi certamente il punto di verifica della capacità della destra di consolidare il suo blocco sociale ed elettorale. Una coalizione che andrebbe indagata più a fondo, anche per coglierne gli elementi di contraddizione. Non possiamo dimenticare che il 2027 sarà anche un anno elettorale cruciale per la Francia e la Spagna. Salvo mutamenti non prevedibili, si voterà in aprile per la nuova presidenza della Repubblica francese e a giugno per il parlamento spagnolo. Lo stato attuale dei rapporti di forza elettorale sembrano indicare un’ascesa dell’estrema destra in entrambi i Paesi. Se così fosse, assieme all’Italia, avremmo governi le cui radici si collocano rispettivamente nel fascismo, nel franchismo e in Vichy.
A quel punto, tra i paesi fondatori dell’Unione Europea, resterebbe solo la Germania governata da partiti tradizionali. Ma anche in questo paese, considerata la forza consistente che mantiene l’AfD, lo spostamento a destra della direzione della CDU, il continuo declino della socialdemocrazia, non si escludere che prima o poi, e forse più prima che poi, cada anche quel muro difensivo che finora ha tenuto lontana l’estrema destra tedesca dal Governo (si veda in proposito l’articolo che pubblichiamo questa settimana, ripreso dal sito della Fondazione Rosa Luxemburg).
Gli elettori saranno probabilmente chiamati a decidere se l’Italia resterà parte integrante di questa Europa che si tinge di nero oppure provare ad aprire una fase di controtendenza.
Un altro elemento che pone problemi inediti alla sinistra di trasformazione è dato dall’arretramento complessivo di tutta la sinistra, includendo in questo campo, pur con tutte le contraddizioni note, sia la socialdemocrazia che i Verdi. Ascesa della destra autoritaria e reazionaria da un lato, crisi di consenso della sinistra nel suo complesso, mettono necessariamente la sinistra di trasformazione di fronte alla necessità di compiere scelte diverse.
Per un periodo, successivo alla caduta del blocco socialista, è stato necessario mantenere aperto uno spazio politico ed elettorale per la sinistra di trasformazione, fosse essa di derivazione comunista o di diverso orientamento politico-ideologico. In un passaggio successivo, determinato dalla crisi del debito sovrano avviata nel 2008, si è pensato che la sinistra di trasformazione potesse imporsi come forza prevalente di tutto l’arco della sinistra. In particolare ciò si fece intravedere in Grecia con Syriza e in Spagna con il primo Podemos. La crisi della socialdemocrazia, non compensata dall’ascesa dei Verdi, portò ad identificare quel fenomeno che veniva chiamato come “pasokizzazione”, per indicare il declino della socialdemocrazia greca e l’ascesa di una sinistra più radicale, come nuovo paradigma possibile per il resto dell’Europa.
Questa fase è anch’essa superata, per varie ragioni che qui non si possono analizzare. Questa pone alla sinistra di trasformazione un orizzonte diverso da quello precedente. Non c’è dubbio che la sinistra per tronare a vincere, debba necessariamente essere plurale. Altrettanto certo è che una sinistra che si proponga di riconquistare il potere politico abbia l’esigenza di avere al suo interno un settore di maggiore radicalità portatore di un progetto storico di mutamento sociale a favore delle classi lavoratrici, delle classi popolari e dei movimenti sociali antisistemici.
Questa sinistra portatrice di un progetto di alternativa deve essere in grado di ripensare la propria capacità di insediarsi in termini politici ed elettorali in questa coalizione del cambiamento, ma in questo modo deve anche porsi il tema di agire come forza trainante, anche laddove minoritaria, della controffensiva messa in campo da una sinistra larga e plurale.
Se, pur in termini diversi, resta necessaria la prospettiva che è stata definita delle “due sinistre”, occorre misurarsi col fatto che oggi queste due sinistre, oltre ad avere tutte le difficoltà note nel convergere su programmi politici convincenti, spesso rappresentano, anche sommate, parti sempre più ridotte della società e di questo si trova espressione lampante nei dati elettorali.
Ascesa della destra autoritaria e reazionaria con elementi di fascismo, spostamento delle classi capitalistiche dominanti dalla gestione centrista dell’alternanza verso l’estrema destra, necessità della sinistra di trasformazione sia di ripensare sé stessa in funzione del rapporto con le classi lavoratrici e popolari sia di contribuire ad una ripresa di un più largo schieramento di sinistra e progressista (un nuovo frontismo) mi sembrano i tre dati politici fondamentali sulle quali costruire progetto e strategia.
Ovviamente questi elementi definiscono più specificamente la dimensione politico-ideologica (in altri tempi si sarebbe detto sovrastrutturale) che va necessariamente inserita nelle dinamiche strutturali, ovvero nei diversi processi in atto che hanno come caratteristica ineliminabile la tendenza del capitalismo a produrre contraddizioni e a cercare continuamente di superarle determinando cambiamenti nella sovrastruttura.
La definizione di un progetto politico e di una strategia di medio periodo richiede di articolare l’analisi su tre diversi livelli: lo scenario politico-istituzionale, lo scenario elettorale e lo scenario sociale.
Ma innanzitutto da questo scenario così sintetizzato occorre trarre l’indicazione sulla proposta politica fondamentale. Rispetto a chi propone opzioni semplificate, l’ingresso comunque sia nel centro-sinistra (cosiddetto “campo largo”) che risulti subalterno o la costituzione di un polo elettorale alternativo al centro-sinistra, penso invece che occorra definire una proposta che tenga insieme due elementi fondamentali: la sconfitta della destra nelle elezioni del 2027 e la costruzione di una coalizione sociale ed elettorale maggioritaria attorno ad un programma di rottura con le politiche del decennio dei governi tecnici, di unità nazionale e di austerità. Questo periodo di tempo aperto dal governo Monti e chiuso dal governo Draghi.
Avendo la piena consapevolezza che la temporalità dei due elementi non è coincidente, perché nel 2017 si porrà immediatamente il primo obbiettivo ma è poco realistico che si possa realizzare interamente il secondo.
Scenario politico
La prospettiva nella quale ci troviamo non può escludere una lunga fase di permanenza della destra al governo dell’Italia. Al momento tutti i sondaggi indicano che FdI resta saldamente il primo partito e complessivamente la coalizione di governo raccoglie il 47-48% dei voti, mentre l’ipotetico “campo largo”, i cui confini non sono ancora definiti, resta ancorato al 42-43%.
Una seconda legislatura di governo di destra, guidato da Giorgia Meloni, potrebbe profilarsi come un salto più deciso nel processo di decostruzione dell’assetto costituzionale, di controllo di quelli che Althusser chiamava gli apparati ideologici di Stato e di attacco diretto a tutte le residue posizioni organizzative del movimento operaio (in particolare i sindacati). Pur in proporzioni diverse è del tutto possibile una seconda legislatura molto più simile alla seconda presidenza Trump con tutti gli elementi di smantellamento delle difese democratiche che ancora la Costituzione garantisce piuttosto che una semplice continuazione dell’esistente. Il possibile futuro candidato del Rassemblement National alla presidenza della Repubblica francese, Jordan Bardella, ha dichiarato che intende fare della Francia il “paese più repressivo” d’Europa. E potrebbe essere questo il contesto di questa seconda fase del governo delle destre.
Questa tendenza sarà ulteriormente inasprita dal convergere delle politiche di riarmo, in un contesto di crescente militarizzazione, e dai vincoli dell’austerità che il governo ha fatto propri anche al di là delle previsioni europee. Disincentivare il conflitto sociale in ogni sua forma, obbiettivo che è già presente in una serie di norme repressive messe in campo dal governo, diventerà un obbiettivo ancora più impellente. Senza contare quello sdoganamento di un senso comune reazionario, aggressivo e verbalmente (per ora) violento che con la presenza di questo governo si riscontra facilmente frequentando le reti sociali.
Questo è un dato fondamentale dello scenario politico. L’altro riguarda la configurazione delle forze di opposizione. Dobbiamo riscontrare la presenza di due processi oggettivi che si sono determinati nell’arco di un ventennio. Innanzitutto il fallimento del tentativo veltroniano di assorbire tutto lo schieramento di opposizione all’interno di un PD centrista nella dimensione socio-economica e con un vago immaginario liberal di importazione statunitense.
Il PD, che puntava ad essere tutto, oggi deve ammettere che può tornare a vincere le elezioni solo all’interno di una coalizione ampia e di quella potenziale coalizione è destinato a rappresentare circa la metà o poco più dell’elettorato: 22-23% del 46-47% complessivo necessario alla vittoria.
L’attuale leadership democratica di Elly Schlein ha portato ad una correzione politica del PD, da una linea social-liberale (più liberale che sociale) che si proponeva con gestore politico di riferimento affidabile per le classi dominanti, ad una tendenzialmente socialdemocratica. Questa operazione di ricollocazione non solo politica ma anche sociale del PD sconta numerose contraddizioni, sia nella sua capacità di formulare un progetto complessivo, sia nella persistenza di un ceto politico locale notabilare e spesso trasformista. Come si è detto dei socialisti francesi dopo la presidenza Hollande, il PD non è ancora riuscito a recuperare, presso settori popolari, una credibilità che si è persa abbondantemente nel decennio dell’austerità e dell’unità nazionale.
Nonostante queste contraddizioni (e la stessa socialdemocrazia francese, spostata a sinistra da Olivier Faure, sembra tornare sui suoi passi proprio a causa del ritorno in azione dello stesso Hollande) la presenza dei 5 Stelle e di AVS, consente di offrire un profilo diverso dell’alternativa alla destra.
Una parte del gruppo dirigente del PD è consapevole che questo partito non può vincere le elezioni senza una correzione di rotta rispetto all’Agenda Draghi del 2022, ma un’altra parte non è disponibile ad accettare una proposta politica che non sia saldamente ancorata agli interessi di potere economico-finanziario (inclusa la rendita immobiliare) e totalmente appiattita sull’atlantismo.
L’esito di tutto ciò è che al momento esiste un relativo disallineamento tra classi capitalistiche italiane e la configurazione dell’opposizione. Queste classi sono sostanzialmente soddisfatte della politica ossequiente del governo Meloni ma hanno anche l’ambizione di avere non solo un governo amico, ma pure un’opposizione amica, perché non si sa mai. Sembra difficile che questa offensiva che punta a scalzare Schlein e a riportare a destra la potenziale coalizione dell’opposizione, al punto anche da essere disponibile a romperla come nel 2022 e quindi sancire la vittoria elettorale della destra, possa prevalere.
Un altro segnale del delinearsi di un contesto nuovo è il tentativo, difficile e per alcuni aspetti contraddittorio come tendono ad essere tutti i processi che riguardano grandi organizzazioni, di ricollocazione della CGIL su una modalità d’azione più conflittuale che può aiutare il processo di mobilitazione di settori sociali messi ai margini nel sistema politico. Anche questo percorso è tutt’altro che consolidato.
Ma il punto non è tanto affidarsi alle previsioni quanto stabilire se per la sinistra di trasformazione questo relativo disallineamento sia un fatto politico utile alla propria prospettiva strategica o meno. Gramsci sosteneva che, quando si apre una frattura anche piccola nel fronte avversario il compito è di provare ad allargare quella frattura, non certo lavorare a ricomporla. Opzione questa normalmente perseguita dalle correnti estremistiche, per le quali più il fronte avverso è compatto (il “partito unico”) e più si determina un vuoto da riempire. Le vicende storiche vicine e lontane dimostrano che non è così.
Scenario elettorale
Se si ritiene che evitare un lungo periodo di governo della destra con una guida e un’impronta di derivazione neofascista sia un problema rilevante per il 2027, occorrerà valutare quali possibilità concrete di iniziativa e di proposta siano consentite dal contesto politico sopra accennato e poi da quello sociale, sul quale tornerò successivamente.
Una parte dell’estrema sinistra ripropone il polo alternativo sia alla destra che al centro-sinistra, con un modello già sottoposto agli elettori nel 2018 e nel 2022, ottenendo nelle due occasioni l’1,13% (pari a 372.179 voti) e l’1,43% (403.149 voti). La domanda a cui rispondere è: perché un’offerta politica che non ha avuto presa elettorale in contesti relativamente più facili, con un PD spostato più a destra dell’attuale e l’assenza di una vera competizione bipolare dovrebbe avere successo in una situazione diversa? Nel 2022, Unione Popolare disponeva anche di un portavoce ampiamente conosciuto dall’elettorato di sinistra, ex sindaco di Napoli, e già candidato di un largo polo alternativo nelle regionali in Calabria. A Napoli città, nonostante la presenza di Luigi De Magistris, UP raccolse circa il 3 e mezzo per cento. Nelle elezioni regionali calabresi la coalizione di sinistra alternativa al centrosinistra raccolse il 16,17%, pari a 128.204 voti. Un anno dopo, nelle elezioni politiche, UP, nonostante la presenza di De Magistris, ottenne il 2,27% con 16.366 voti. A conferma che è difficile trasferire un voto di livello amministrativo verso il voto politico.
Occorre avere presente la tendenza al posizionamento degli elettori per comprendere quale progetto politico può trovare consenso. Il corpo elettorale, sulla base del voto del 2022, può essere scomposto in tre grandi insiemi. La destra raccolse 12.305.014 voti, pari al 43,79%, le forze del “campo largo” (PD, 5 Stelle, AVS) raccolsero andando separate 11.675.590 voti pari al 41,55%. Il terzo polo centrista raccolse 2.186.505 voti pari al 7,78%.
La decisione della leadership del PD di presentarsi alle elezioni rifiutando l’alleanza coi 5 Stelle in nome dell’adesione all’Agenda Draghi si è rivelata catastrofica soprattutto perché ha consentito alla destra di conquistare 121 seggi alla Camera dei Deputati su 146 per la parte maggioritaria e di lasciare all’opposizione solo 22 seggi. Una ripartizione non corrispondente ai reali rapporti di forza nel voto popolare.
Sembra molto probabile che il voto del 2027 avverrà attorno a due poli strutturati e con una reale competizione per il governo del Paese e che la sostanza della posta in gioco a cui si troveranno di fronte gli elettori sarà la conferma o meno per altri 5 anni della guida della destra.
Occorre tenere presente che le ultime elezioni nelle quali la partecipazione al voto è cresciuta, in quel caso del 2,89% e ha raggiunto l’84,24%, ha coinciso con lo scontro tra i due poli guidati da Prodi e Berlusconi, che inglobarono praticamente l’intero spettro politico. L’Unione ottenne il 49,81% dei voti e la Casa delle Libertà il 49,74%. Fuori dalla polarizzazione restò solo lo 0,45% dell’elettorato. In termini di voti tra i due schieramenti la differenza fu minima ed entrambi si aggiudicarono circa 19 milioni di voti (19.002.598 contro 18.977.843).
Nelle elezioni del 2022, i voti validi sono stati 28.098.196, ovvero circa dieci milioni in meno del 2006. Certamente pesano vari fattori sull’incremento dell’astensionismo come composizione demografica, maggior numero di elettori all’estero e così via, ma il dato sembra indicare che una più notte competizione fra i due poli maggiori, realmente competitivi per il governo (anche quando poi le differenze programmatiche sia meno profonde di quanto appaia dalla propaganda), porti ad una maggiore mobilitazione degli elettori.
Su questa tendenza pesa l’effetto indotto dall’abitudine al meccanismo maggioritario, allo spostamento dell’oggetto della competizione elettorale dal terreno della rappresentanza, nel quale fa premio il pluralismo, alla scelta sul governo. Anche il crescente spostamento dell’equilibrio di potere dal Parlamento, ruolo di confronto e anche di possibile ricerca di compromesso sociale com’era al tempo dei partiti di massa, al netto prevalere dell’esecutivo, modifica il comportamento degli elettori.
Se le elezioni del 2027 saranno maggiormente bipolari e realmente competitive tenderanno ad assorbire la gran parte dell’elettorato trasformandosi in una sorta di referendum sul governo uscente.
Questo pone il problema per la sinistra di trasformazione di individuare quale sia la parte dell’elettorato a cui rivolgersi prioritariamente. L’elettorato di destra, circa 13 milioni di elettori, tra i quali sono naturalmente presenti settori popolari e di classe lavoratrice importanti, sembra difficilmente conquistabile in tempi brevi. Una parte di questo elettorato si è spostato a destra anche in contestazione delle politiche del centrosinistra, ma questo è avvenuto su temi che li ha resi più impermeabili ad un discorso maggiormente orientato a sinistra: immigrazione, sicurezza, fisco, diritti civili.
Le analisi politologiche tendono a sottolineare che si è creata una stabilità dell’elettorato tra i due grandi campi della destra e della sinistra (“il muro di Arcore”) e che il successo o la sconfitta sono determinati innanzitutto dalla capacità di unificare la proposta elettorale e in secondo luogo dalla mobilitazione del proprio elettorato.
Più complesso evidentemente il ragionamento rispetto agli astensionisti. Si può ritenere che sia difficile riportare al voto chi ormai da molti anni è uscito di fatto dal sistema politico. Ma solo fra il 2018 e il 2022 circa 4 milioni di elettori sono diventanti astensionisti. La quasi totalità di questi avevano votato nel 2018 per i partiti di quello che ora dovrebbe costituire il “campo largo”. Di questi una parte significativa erano elettori che avevano sostenuto i 5 Stelle.
La proposta avanzata dalla sinistra di trasformazione dovrebbe rivolgersi da un lato agli elettori di centro-sinistra che hanno come priorità la sconfitta della destra ma condividono la necessità di una correzione almeno parziale di direzione politica rispetto all’agenda neoliberista e dall’altra di provare a rimotivare una parte dell’elettorato dei 5 stelle che si è rifugiato nell’astensione. Questo elettorato nel 2022 non ha trovato credibile la proposta di Unione Popolare, nonostante la leadership di De Magistris, non priva di elementi populisti, sulla carta, sembrasse potenzialmente in grado di intercettarla.
L’astensionismo sempre evocato da chi si attende miracolosi successi elettorali è un fenomeno piuttosto complesso e che andrebbe scorporato nei sei diversi elementi costitutivi. Sulla base delle esperienze che si sono potute verificare in altri Paesi (e quindi da assumere con il necessario senso critico) si può ritenere che la mobilitazione dell’astensionismo abbia bisogno di due elementi. Il primo è l’effettiva rilevanza della posta in gioco elettorale.
Se prendiamo la vittoria di Zohran Mamdani si vedrà che questa presenta un carattere fondamentale. Non basta come qualcuno ha sostenuto presentare un “programma radicale” per vincere le elezioni, altrimenti la sinistra di trasformazione o l’estrema sinistra vincerebbero tutte le elezioni alle quali si presentano.
Mamdani non ha solo proposto un programma (moderatamente) radicale ma lo ha anche collegato ad una strategia credibile di conquista del potere politico necessario a realizzarlo. Nel suo caso è stata una strategia che definirei come dell’essere “dentro” e dell’essere “contro”. Contro l’establishment conservatore del Partito Democratico ma dentro il percorso elettorale dello stesso partito essendo questa una condizione ineliminabile per una vittoria elettorale nel contesto bipolare.
L’altro elemento che sembra fondamentale per mobilitare settori di astensionisti (oltre alla strategia per il potere) è di riuscire a contattare direttamente (non solo attraverso le reti sociali) questi elettori lontani dal sistema politico. Ciò richiede una capacità di mobilitare migliaia di persone per un’opera volontaria di “canvassing” (porta a porta), come si è visto a New York o anche nella campagna della Linke, perché come ha segnalato Antonio Floridia, il voto va anche chiesto attraverso il contatto personale. E questo non è facile in assenza di partiti che abbiano dimensioni di massa, ma diventa un obbiettivo per molti aspetti decisivo.
Se l’elettorato che intende orientarsi verso l’opposizione di centro-sinistra diventa, allo stato dei fatti il primo interlocutore della sinistra di trasformazione ne deriva la necessità di pensare ad una forma di collaborazione che, all’interno di questo scenario probabile di polarizzazione elettorale, possa tornare a rendere visibile la sinistra di alternativa come fattore politico oggi inevitabilmente minoritario ma significativo nel panorama politico nazionale.
L’intreccio dei due obbiettivi politici che si sono individuati (sconfitta della destra e programma di rottura) impone di tenere fermo, nel 2027, il primo obbiettivo, lasciando aperto uno spiraglio per la realizzazione del secondo, il quale richiede necessariamente un mutamento più complessivo dei rapporti di forza politici e sociali.
All’interno di una prospettiva “frontista” di cui ho già parlato in questo sito è possibile orientarsi tra un obbiettivo minimo, il “fronte democratico-costituzionale” o “Patto per la Costituzione” e un programma di convergenza programmatica più ampio nella forma di un “fronte popolare”. Questo, storicamente non ha solo caratteristiche difensive, ma si configura come concreta possibilità di ottenere risultati concreti per le classi lavoratrici e popolari.
Una proposta analoga venne presentata da Rifondazione Comunista in vista di elezioni politiche anticipate che avrebbero dovuto tenersi a seguito della crisi del governo Berlusconi nel 2010-2011. La proposta venne avanzata pubblicamente ma saltò nel momento in cui il Presidente Napolitano decise che non si sarebbe andati al voto e si aprì la stagione del governo Monti. Nel momento in cui il PD si allontanò da qualsiasi prospettiva di alternativa alla destra quella proposta (che pure aveva già dato occasione ad un inizio di trattativa) cadde necessariamente nel vuoto.
Scenario sociale
Non si può evidentemente separare lo scenario politico e la prospettiva elettorale da una più ampia considerazione di quanto avviene nella società italiana. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da alcuni segnali di mobilitazione certamente positivi ma che non hanno ancora prodotto effetti politici significativi.
Il referendum della CGIL, il cui esito è stato reso più difficile per l’eliminazione del quesito sull’autonomia differenziata, ha comunque indicato un forte consenso ad un ritorno a normative di maggior tutela dei diritti dei lavoratori e lavoratrici. Indicazione evidente che questa è una questione sentita come rilevante da una parte importante della popolazione. Nelle prossime settimane ci saranno due scioperi generali, quello indetto dalla CGIL per il 12 dicembre, e quello promosso da USB e altri sindacati di base a fine novembre. La possibilità di convergenza su un’unica data, tema superato visto che la CGIL ha operato legittimamente una scelta diversa, e che l’USB ha confermato la propria ostilità di principio e di lunga data a convergere con il maggiore sindacato italiano, ciò che ora conta è l’esito positivo di questi appuntamento di mobilitazione su temi politico-sociali. Lo sciopero del 3 ottobre in solidarietà del popolo palestinese è stato un’eccezione determinata dalla forte spinta dal basso e dalla natura non strettamente sindacale della mobilitazione.
Le manifestazioni per la Palestina ed in particolare per il sostegno alla Flotilla, bloccata illegalmente dagli israeliani in acque internazionali, hanno registrato un netto salto di partecipazione e di coinvolgimento, proprio grazie all’iniziativa delle navi che hanno cercato di rompere il blocco attorno a Gaza, che ha dissolto in parte quel senso di impotenza che si è a lungo registrato nelle mobilitazioni di solidarietà e di opposizione al genocidio. Per lungo tempo le iniziative hanno coinvolto qualche migliaio o qualche decina di migliaia di manifestanti, per lo più da tempo sensibilizzati sulla questione palestinese. La prima manifestazione con dimensione di massa è stata organizzata dalle forze politiche di opposizione. Indicazione forse anche di un limite nella conduzione delle mobilitazioni precedenti.
Tra il 22 settembre e il 4 ottobre si è sviluppato un fortissimo movimento di solidarietà che ha visto una partecipazione straordinaria di ragazzi e ragazze che non si è riscontrata in tante altre occasioni. Sembra difficile, anche per la sua evidente strumentalità, che questa partecipazione sia immediatamente ricondotta alla dimensione elettorale, come subito tentato da alcuni soggetti politici e sindacali.
Emerge comunque una disponibilità a esprimere la propria indignazione, anche in forme radicali e giustamente non violente, attorno ad una questione, come quella emersa a Gaza, che tocca corde profonde di sensibilità umana e come espressione di un forte senso di ingiustizia, di fronte al genocidio ma anche alle complicità estese verso lo stesso genocidio. Come orientare e far pesare questa sensibilità anche su altri temi (questioni sociali, opposizione al riarmo e alla guerra, cambiamento climatico, ecc.) è un interrogativo aperto sul quale occorrerà una più profonda riflessione.
Resta aperto il terreno della costruzione di una piattaforma politica che modifichi profondamente la politica italiana sulla questione palestinese. L’Italia ha una lunga tradizione di solidarietà che non ha riguardato solo il Partito Comunista, ma anche quello socialista e in molti casi la stessa Democrazia Cristiana. La compagine guidata da Giorgia Meloni, per ragioni ideologiche data l’affinità con l’estrema destra israeliana, e per una generale tendenza alla subalternità con tutti i poteri che potrebbero creare problemi alla sopravvivenza del governo, non ha sviluppato alcuna iniziativa politica o diplomatica in questi anni. Al contrario ha continuato a sostenere tutte le forme di supporto alla politica genocidaria del governo di Tel Aviv.
Una nuova politica mediorientale dell’Italia dovrebbe essere uno dei punti fondamentali della piattaforma elettorale e di convergenza all’interno di quello che abbiamo indicato come “fronte” o “patto” costituzionale.
Così credo che valga anche in relazione agli altri temi posti dalle mobilitazioni (certamente diverse per estensione e caratteristiche) che si sono realizzate in questi mesi. Innanzitutto quelle già citate relative ai diritti e alla condizione salariale dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche sull’opposizione alle politiche repressive e securitarie del governo, all’autonomia differenziata, il rifiuto della militarizzazione della scuola e così via.
Ovviamente è centrale la questione delle politiche di riarmo e della posizione politica dell’Italia rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina. Dal prossimo anno si faranno più stringenti le politiche di bilancio finalizzate ad ottemperare a politiche di riarmo che sono del tutto inaccettabili. Questo è evidentemente un terreno complicato, date le divergenze esistenti nell’opposizione e l’offensiva permanente messa in atto dalle componenti più belliciste e illiberali della destra del PD, sostenute da un ampio apparato mediatico, ma fondamentalmente invise a gran parte dell’opinione pubblica che fa riferimento al centro-sinistra. Questi settori hanno posizioni più oltranziste dello stesso governo e determinano una permanente perdita di credibilità per qualsiasi costruzione di un’alternativa alla destra.
Lo sviluppo delle mobilitazioni sociali e il loro allargamento costituisce una condizione fondamentale per determinare quella prospettiva di medio-lungo termine di affermazione di un programma di rottura rispetto alle politiche che uniscono neoliberismo-austerità-tendenze autoritarie. Ma esse già oggi forniscono alcuni elementi fondamentali per la costruzione del “fronte per la Costituzione”.
Per la sinistra di trasformazione si pone anche un problema più ampio che riguarda la capacità di ricostruire in termini nuovi, perché nuova è la configurazione sociale, una identità di classe. È senso comune che si sia determinata una frattura fra la sinistra (non solo la parte moderata e social-liberale ma anche di quella alternativa) e le classi popolari. Questo si riscontra sul terreno elettorale ma non può essere risolto esclusivamente a partire dal momento elettorale. Il contributo alla sconfitta della destra passa anche, se non soprattutto, dalla capacità della sinistra di trasformazione, o almeno per quella parte che si pone in questa prospettiva, di tornare a rappresentare le classi popolari e lavoratrici e a dare ad esse forza e protagonismo.
La prospettiva non può che essere quella di ricostruire una coalizione politica, sociale ed elettorale maggioritaria che si proponga la conquista del potere politico ai fini di estendere una democrazia che deve basarsi sulla giustizia sociale e sulla libera espressione del conflitto.
Franco Ferrari